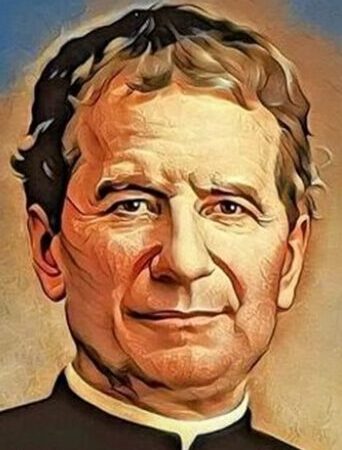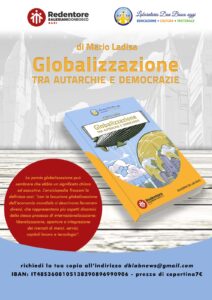L’Autonomia differenziata
La Costituzione italiana al Titolo V° art.114 prevede che “ :
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
Il successivo art.117 attribuisce le materie in cui lo Stato e le Regioni hanno potestà legislativa. In particolare, spetta allo Stato centrale legiferare, tra l’altro, sulla politica estera, immigrazione, difesa, organizzazione dello Stato, ordine pubblico ecc. Al comma 4 si legge: “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

La legge costituzionale n. 3/2001 ha modificato in alcune parti il titolo V°, ampliando a dismisura le materie che le Regioni possono richiedere di propria competenza legislativa nella presunzione, non dimostrabile, che possano essere gestite meglio e con migliori risultati di quanto fatto dallo Stato Centrale.
Ora si tratta di concretizzare queste attribuzioni, spostarle in alcuni casi, come si dirà appresso, dallo Stato alle Regioni; non solo, ma anche in maniera diversa tra le stesse Regioni: una vera frammentazione di poteri legislativi, amministrativi, economici e finanziari.
Non è un caso che le tre Regioni richiedenti la così detta autonomia differenziata siano le più ricche del Paese, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e questo significa che hanno una potenzialità di partenza per governare tutte le 23 materie che hanno chiesto che passino dallo Stato alle loro Regioni.
Ecco un elenco semplificativo:
Le norme generali della istruzione, i programmi, gestione della scuola, stipendi degli insegnanti, concorsi per gli stessi tutti su base regionale; reti ferroviarie, strade ed autostrade, porti, demanio, gestione del territorio.
Per poter gestire le nuove funzioni, occorrono delle risorse finanziarie aggiuntive a quelle che le Regioni ricevono con la loro tassazione su base regionale (Irpef ed Irap). Considerato la unitarietà del Paese, il trasferimento di risorse dallo Stato centrale alle Regioni richiedenti l’autonomia differenziata, comporta necessariamente la contrazione della fiscalità generale necessaria allo Stato per far fronte ai suoi notevoli fabbisogni per gestire a sua volta, le sue competenze.
Ora esiste un obbligo costituzionale per lo Stato di effettuare una perequazione in base all’art.117 c. 2 per aiutare i territori, regionale, provinciale e comunale che si trovano in particolare difficoltà economica e finanziaria.
Lo Stato provvede attualmente alla perequazione con i residui fiscali delle Regioni e con le proprie tasse, mentre il fabbisogno è determinato dalla così detta spesa storica. Se ricevevi per la gestione dell’Università 1.000 euro ne avrai altrettanti, se ricevevi 100 avrai la stessa cifra, consolidando pertanto una disparità incolmabile.
Il ricorso alla spesa storica è stato un rimedio alla mancata applicazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni); “ I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Ma tali diritti devono essere considerati concretamente e non per pronunciamenti generici; il diritto alla salute, alla formazione, allo sviluppo, al lavoro deve essere garantito su tutto il territorio italiano.
Purtroppo quando si entra nei particolari dei LEP la vicenda si complica.
1) Chi decide cosa, quanto e come identificare i LEP nelle varie Regioni;
2) Chi e con quali risorse i LEP devono essere realizzati.
E’ stato valutato che per assicurare a tutti i territori le medesime prestazioni occorrerebbero decine di miliardi: impossibile da spendere per il notevole debito pubblico italiano (tra i più critici nel mondo) e per il patto di stabilità vincolato dall’Europa affinchè i bilanci degli Stati europei e quindi il deficit non superi il 3% del Pil. (disavanzo netto tra entrate ed uscite), mentre il debito pubblico non sia superiore al 60% del Pil. Il deficit ed il debito italiano attualmente superano di gran lunga i parametri europei; pertanto l’Europa ha iniziato la procedura dettando i tempi e le modalità del rientro dalla situazione debitoria. Per l’Italia circa 10 miliari l’anno.
Il Governo sa di stare nella obiettiva difficoltà di dare attuazione ai LEP; resta pertanto in atto il metodo della spesa storica.
Per fortuna il PNRR riesce, se attuato, ad integrare i progetti di crescita, con i finanziamenti destinati dall’Europa fino a 109 miliardi. L’ingente somma può incidere sulla scuola (palestre, digitalizzazione, sicurezza dei siti), asili nido che consentano alle donne con bambini, di continuare a lavorare piuttosto che abbandonare il posto di lavoro per l’impossibilità ad accudire il figlio; ferrovie distribuite su tutto il territorio nazionale più veloci, sicure, con collegamenti utili al mondo produttivo e soprattutto ai milioni di studenti che si spostano giornalmente, investimenti sulle aziende strategiche anche con la partecipazione dello Stato.
Se tutto questo si realizza, non si vede quale interesse possano avere le Regioni a differenziarsi ulteriormente dallo Stato perché l’insistenza soprattutto della Lega, non lascia dubbi che la vera ragione è una mal celata secessione dei ricchi.
In una situazione europea che richiede sempre più che le nostre economie non siano sopraffatte dalle potenze sempre più ingombranti della Cina, Stati Uniti, India, Russia, il frazionamento delle competenze, non può che indebolire il quadro nazionale. Non si potranno fare proposte in Europa distinte per Regioni, si creeranno conflitti tra Regioni e tra Stato e Regioni.
Molti economisti hanno dato l’allarme perché questa riforma non passi.
Infine la stessa Conferenza Episcopale Italiana ha espresso notevoli riserve sulla proposta di riforma perché minerebbe le basi della solidarietà tra i territori, aumentando le disparità dei servizi.
Se perdiamo l’unità del Paese realizzata con il sacrificio dei nostri Padri, avremo perso tutti perché un mancato sviluppo del Sud non potrà essere indolore anche per il ricco Nord.
Mario Ladisa